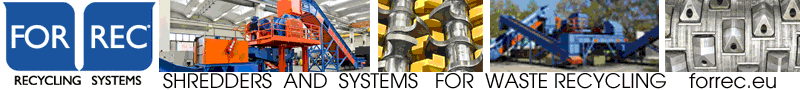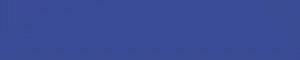«Là sotto», lo chiamano i piemontesi della zona. Un avvallamento lungo la Dora Baltea, affluente del Po. Qui, a trenta metri dal fiume, dietro recinti, filo spinato, terrapieni e muri anti-alluvione, sta il comprensorio nucleare di Saluggia, piccolo Comune in provincia di Vercelli. Se sull’energia atomica si incontrano posizioni diverse anche fra gli addetti ai lavori, Saluggia ha il merito di mettere d’accordo tutti.
È infatti unanimemente considerato il sito più inadatto in cui stoccare dei rifiuti radioattivi. Perché i depositi di scorie, al contrario delle centrali nucleari, devono stare lontani dall’acqua. E qui invece stiamo al centro di un triangolo, tracciato dalla Dora Baltea e due canali. Sotto passano le falde acquifere che alimentano l’acquedotto del Monferrato.
«Anni fa abbiamo avuto il primo caso nel Paese di contaminazione di una falda superficiale», commenta Gian Piero Godio, storico attivista di Legambiente Vercelli, mentre percorriamo il perimetro del sito. E proprio qui, mentre l’Italia si avvita da anni su come, dove e quando fare un deposito nazionale in cui mettere al sicuro tutti i rifiuti radioattivi, sorge il deposito nazionale de facto. Qui – con il contributo minoritario di Trino, sempre nel Vercellese – stanno il 73 per cento dei rifiuti nucleari italiani, se si misura la radioattività; e il 96 per cento, includendo altri materiali radioattivi (fonte inventario Ispra 2014). E ancora qui, nell’impianto Eurex, stanno 260 metri cubi di rifiuti liquidi, ovvero nella loro forma più pericolosa, che attendono di essere solidificati da molti anni.
Sul sito è in costruzione un complesso, Cemex, che dovrà cementarli. «Nel giugno 2016 è stato fatto il getto della platea di fondazione, ora è in corso la costruzione delle pareti», commenta Marco Sabatini Scalmati, responsabile relazioni media di Sogin, la società pubblica incaricata della disattivazione degli impianti nucleari, che gestisce questo e altri siti. I lavori dovrebbero concludersi, sulla carta, nel giugno 2019. Nel mentre, lì dentro si sta ingrandendo un deposito di cemento, il D2, e se ne sta costruendo un altro, il D3. Per Sogin consentiranno di stoccare in maggior sicurezza i rifiuti in vista del loro trasferimento in un deposito nazionale. Per gli ambientalisti però il timore è che servano a rendere definitivo quello che è temporaneo. «Ha senso farli se tra pochi anni i rifiuti verranno trasferiti? Oppure il loro destino è di essere definitivi?», si chiede Godio.
Era il 1999 quando per la prima volta in modo ufficiale si iniziò a parlare di un deposito nazionale dove mettere al sicuro le scorie della breve stagione nucleare italiana. Addirittura, una legge del 2003, dopo averlo definito «indifferibile e urgente», lo voleva entro soli cinque anni. Più sagge stime lo avrebbero collocato nel 2020, salvo poi far slittare progressivamente le date – insieme ai costi generali dello smantellamento del nucleare – in un tunnel di cui ad oggi non si vede la fine. Così, nel 2017, la realizzazione di un deposito unico, di cui si parla da almeno 17 anni, resta poco più di un miraggio. E dire che nell’estate 2015 si era intravisto il traguardo, quando doveva essere pubblicata dal governo la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee per ospitarlo.
Una lista di località, redatta in gran segreto, che non è mai uscita dal cassetto e la cui pubblicazione servirebbe a iniziare le complesse trattative per arrivare infine a definire il posto più adatto. E da lì iniziare a costruire il deposito. La Sogin, i cui vertici sono stata rinnovati lo scorso luglio dopo anni di travagli interni, ci aveva fatto pure una campagna informativa nel 2015, con 4,1 milioni di euro spesi in comunicazione. Ma la pubblicazione della fantomatica carta non c’è stata, così come non è stato ancora realizzato il Programma nazionale italiano per la gestione dei rifiuti nucleari. Ovvero un documento, previsto da una direttiva europea, con cui ogni Stato è tenuto delineare la propria strategia al riguardo. Lo scorso febbraio l’Italia ha presentato solo un rapporto preliminare.
«Il Programma nazionale deve essere sottoposto a una Valutazione Ambientale Strategica, che a sua volta si fa sulla base di un rapporto ambientale. L’Italia ha prodotto un documento preliminare di questo rapporto ambientale propedeutico», commenta Roberto Mezzanotte, già direttore del dipartimento nucleare di Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
«Dunque siamo due passi indietro rispetto all’obiettivo, che è il Programma nazionale. Per altro quel rapporto preliminare ha molte lacune». Così, ad aprile l’Europa ha iniziato una procedura d’infrazione contro l’Italia per la mancata consegna di tale programma. E a settembre il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, in un’audizione, ha infine fatto sapere che la Carta dovrebbe essere pubblicata a fine 2017, legandola a sua volta al Programma nazionale. Per qualcuno sarebbe già un successo, a questo punto, se il deposito, prima vagheggiato nel 2020, poi slittato verso il 2024-25, fosse pronto intorno al 2030. Ma parallelamente a questo tema, si aggiunge la questione dello smantellamento (decommissioning) degli attuali siti temporanei, che ospitano rifiuti e altri materiali radioattivi. Smantellamento che non avverrà prima del 2035, stando allo stesso rapporto preliminare del governo. «Nel luglio 2016, l’avanzamento del decommissioning era attorno al 25 per cento», commenta Sabatini Scalmati. Nel 2012 era al 12 per cento. Intanto, l’allungamento dei tempi fa aumentare quanto paghiamo, «perché ci sono spese fisse indipendenti dal procedere delle operazioni di decommissioning», spiega Mezzanotte. Mentre tra il 2006 e il 2011 i costi per la messa in sicurezza e lo smantellamento sono aumentati del 42 per cento, attestandosi su una stima di 6,7 miliardi. Poi ci sarebbe la partita dei rifiuti che devono rientrare dall’estero, termine ultimo il 2025. Se, come è ormai probabile, per quella data non ci sarà il deposito, dove andranno?
«Se il deposito fosse quasi pronto forse si potrebbe ricontrattare con la Francia. Se invece non lo fosse, sarebbe uno dei problemi», commenta Lamberto Matteocci, responsabile controllo delle attività nucleari dell’Ispra. «Bella domanda, non esiste un piano B», aggiunge Mezzanotte. «Ma si potrebbe ipotizzare che ogni sito sia costretto a riprendere i propri rifiuti, o che venga fatto un deposito temporaneo solo per quelli». Esattamente quello che temono gli ambientalisti di Saluggia: non è che quei nuovi grandi depositi in cemento, più che essere solo migliorativi, serviranno anche a questo? Senza contare che ancora manca un’autorità di vigilanza sulla sicurezza. «Non abbiamo un arbitro, un ente indipendente», lamenta Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace.
Doveva essere l’Isin, l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, costituito nel 2014 e non ancora operativo. Il suo ruolo continua ad essere assolto provvisoriamente dall’Ispra. Che però negli ultimi anni è stata depotenziata. «Abbiamo avuto una progressiva riduzione delle risorse. L’Isin prevederebbe circa 60 persone, ora all’Ispra siamo la metà», precisa Matteocci. Nel mentre, la storia del deposito appare sempre di più quella di un cerino passato di mano in mano. Dove perfino i Comuni che ospitano i siti temporanei sembrano aver accettato il dato di fatto. Che si traduce pur sempre in 15 milioni di euro all’anno in compensazioni statali.
Anzi, nel luglio 2016 quei Comuni hanno perfino vinto una causa in primo grado contro il governo. L’accusa è che lo Stato trattenga il 70 per cento dei soldi destinati ai territori sedi di servitù nucleari. «Le compensazioni sono diventate ormai delle entrate strutturali dei bilanci di quei Comuni, se sparissero domani avrebbero dei problemi», commenta Umberto Lorini, direttore della Gazzetta di Vercelli. Una iniezione di liquidità cui è difficile rinunciare in tempi di ristrettezze anche per gli enti locali.